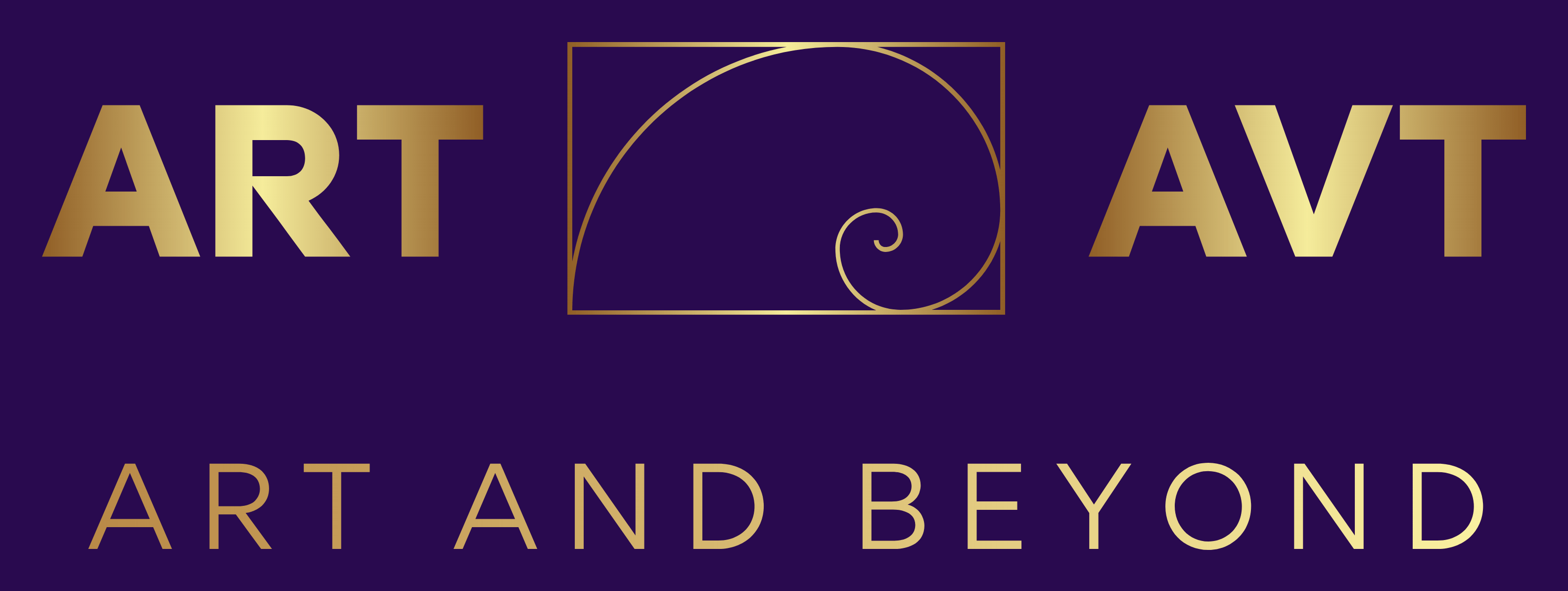A Firenze possiamo ammirare i primordiali esempi di innovazione stilistica a livello architettonico. Un esempio è la sagrestia vecchia in san Lorenzo.
Tra le varie maestranze che hanno contribuito alla vista odierna di Firenze ritroviamo Filippo Brunelleschi. Mentre Brunelleschi costruiva l’ospedale degli Innocenti, gli venne affidato un nuovo incarico, quello della chiesa di San Lorenzo. Il progetto verrà concluso nientemeno che da Michelangelo, il quale si occuperà anche della sagrestia nuova.
ArtAut consiglia
Per approfondire nel dettaglio la storia e le opere d’arte all’interno di questo magnifico complesso, ArtAut vi consiglia la seguente lettura.
Il committente
I Medici, Signori di Firenze, contribuirono a rendere la città un centro culturale europeo che ha dato la spinta motrice alla rinascita culturale dell’intero continente. É qua che il rinnovamento artistico ha inizio grazie alla famiglia medicea, la quale ricerca talentosi e innovativi artisti per rinnovare la città fiorentina.
La famiglia Medici governava Firenze già dal 1400. Il loro patrocinio subirà una breve interruzione a fine secolo. Dovettero abbandonare la città per fare ritorno solo nel 1515.
I Medici alla conquista della chiesa
I Medici non partirono solo a conquista di Firenze, ma anche di Roma. La famiglia Medici si rese protagonista non solo di Firenze ma, grazie ai voti religiosi presi da diversi membri della famiglia, iniziarono a “conquistare” Roma diventando Papi.
Fu proprio un papa mediceo, Leone X , 217º papa della storia, che nel 1513 decise di rinnovare la chiesa di San Lorenzo di Firenze. Gesto atto a onorare il potere riconquistato della sua famiglia.
Un progetto travagliato per la facciata si San Lorenzo a Firenze e la sagrestia vecchia
L’edificio preesistente mostrava ancora una facciata incompleta, che fu il fulcro dell’attenzione per il restauro.
L’ideazione della nuova facciata fu molto travagliata tra indecisioni e numerosi progetti rifiutati.
Brunelleschi propose una facciata che ricordava la facciata di Santa Maria novella, dalla quale riprendeva i marmi colorati che fungevano da decorazione.
Secondo le Vite di Vasari anche Raffaello e Antonio da Sangallo proposero dei progetti. Sfortunatamente non abbiamo alcuna traccia di tali progetti.
Finalmente si arriverà a un accordo: la facciata verrà progettata sotto il disegno di Michelangelo nel 1518. Al Brunelleschi verrà affidata la progettazione della cappella privata della famiglia Medici.
Stile della sagrestia vecchia
San Lorenzo a Firenze di Brunelleschi e Michelangelo è un esempio di sintesi formale tra due stili diversi. Ritroviamo il Romanico, dal quale viene ripresa l’austerità formale, e il Gotico dal quale viene ripreso l’idea dello spazio imponente.
Ratio e dispositio
Spicca la proporzione degli elementi, basata su una ratio e dispositio matematica dei vari elementi architettonici. Vi è una concorrenza alla simmetria e equilibrio tra gli elementi della struttura.
L’armonia dell’esterno e dell’interno possiedono una matrice classica rivisitata in chiave moderna.
Edifici preesistenti alla sagrestia vecchia
La struttura preesistente venne allargata già in precedenza, in modo da somigliare di più alle grandiose chiese e fare spazio al nuovo coro della chiesa.
Successivamente, nel 1421 Giovanni dè Bicci de Medici chiese a Brunelleschi di diventare consulente per il rinnovo della chiesa.
Pianta centralizzante della chiesa e sagrestia vecchia
La pianta si sviluppa tenendo in considerazione il quadrato che si forma nell’incrocio delle braccia della chiesa a croce latina. In questo modo si evidenzia il centro della chiesa e dunque l’idea di spazio centralizzato.
Attorno al punto centrale gli elementi sono ritmati ordinatamente.
Contribuiscono a questo effetto anche le cappelle laterali attorno ai transetti, gli elementi della sagrestia vecchia. A tali elementi si uniranno anche la sagrestia nuova ideata e realizzata da Michelangelo.
Lo spazio della sagrestia vecchia
Lo spazio si espande donando alla basilica un effetto scenografico che si riflette anche sulla scelta decorativa del pavimento. Le decorazioni si sviluppano in altezza. In questo modo anche le decorazioni contribuiscono a dare l’effetto finale di spazialità e grandiosità, slanciando lo sguardo verso l’alto.
La sagrestia vecchia è un vero e proprio esempio dello stile caratterizzante Brunelleschi e di come egli riesce a gestire lo spazio anche tramite la prospettiva.
La cupola della sagrestia vecchia
La cupola si sviluppa in un cerchio, e i pennacchi aiutano a slanciare la cupola verso l’alto, creando una transizione dolce tra il basso e l’alto.
L’attenzione ai pennacchi e alla loro funzione saranno elementi fondamentali per Brunelleschi, il quale li ha studiati attentamente dagli antichi edifici classici, e saranno elementi che caratterizzeranno gli edifici che si susseguiranno nel Rinascimento.
Nuovi utilizzi di vecchi elementi nella sagrestia vecchia
Dal nuovo utilizzo dei pennacchi e della loro funzione nello spazio deriva anche l’idea della volta a vela che si innalza sulla forma cubica della sagrestia. Troviamo un’altra cappella che si trova nella sagrestia nel piccolo coro.
Vi è una costrizione degli spazi che sono complessi ma articolati in maniera armonica e speculare.
Sono presenti elementi particolari che evidenziano la mano dell’artista:
- doppie arcate concentriche
- pilastri
- trabeazioni
- cupola sopraelevata
La logica compositiva degli elementi si ripresenta anche nei piani d’imposta tra capitelli e archi della navata, che si prefigurano anche come trabeazione delle mura.