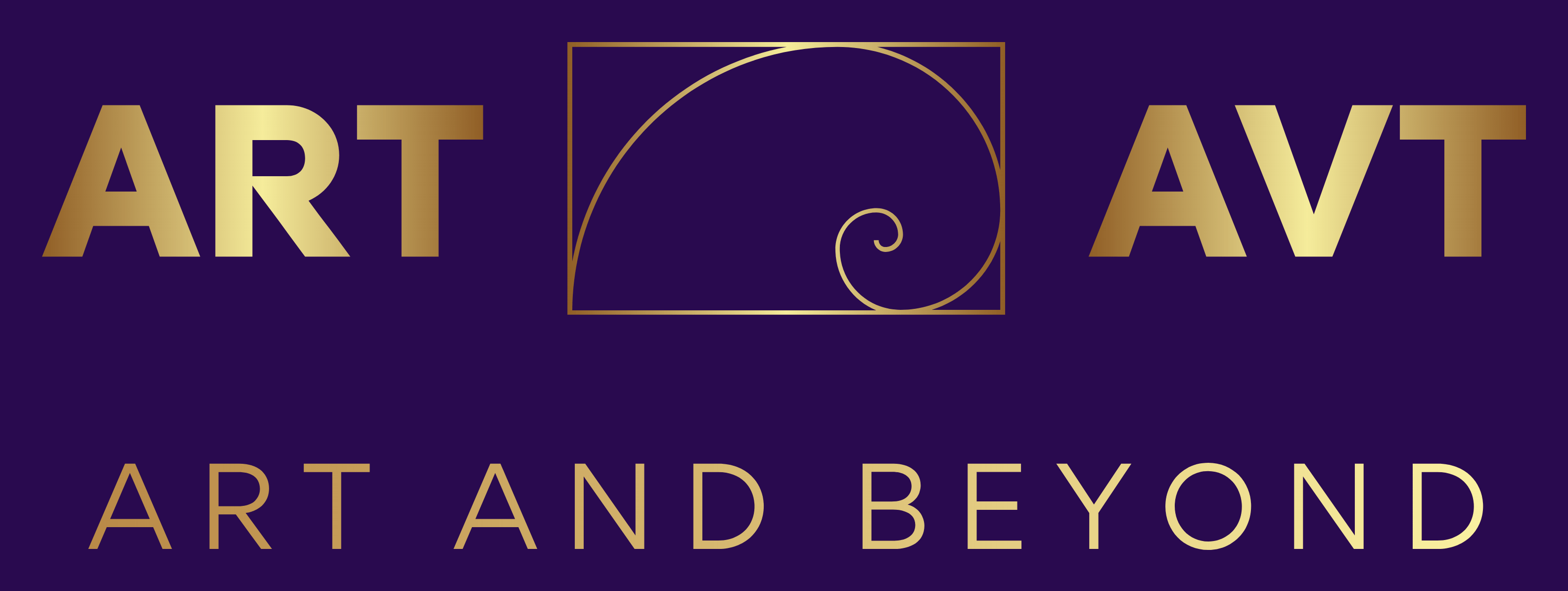Poco dopo la sua elezione (1523), Papa Clemente VII, appartenente alla famiglia fiorentina dei Medici commissionò a Michelangelo la Biblioteca Laurenziana.
La famiglia Medici possedeva una grande collezione di libri che venne tramandata da papa in papa della famiglia Medici.
Quando Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici venne eletto papa Clemente VII decise di rendere pubblica la collezione di libri che fino a quel momento erano stati preservati nei palazzi privati della famiglia.
Una biblioteca medicea per una chiesa Medicea
Da questa generosa decisione nasce l’esigenza di creare le Biblioteche Laurentiane, direttamente collegate alla chiesa di San Lorenzo a Firenze alla quale lo stesso Michelangelo lavorò. Le biblioteche si posizionano nel chiostro ovest della chiesa di San Lorenzo.
Abbiamo avuto modo di parlare della Chiesa di San Lorenzo nei seguenti articoli
- Michelangelo architetto nella chiesa di San Lorenzo a Firenze
- La Sagrestia Vecchia di Brunelleschi a Firenze
L’inizio dei lavori presso la Biblioteca Laurenziana
I lavori presso la biblioteca partirono nel 1525. Michelangelo lasciò il progetto incompleto per partire a Roma, affidando i lavori a tre maestranze del periodo: ovvero Vasari, Tribolo e Bartolomeo Ammannati. Questi tre maestri compirono i lavori seguendo i progetti di Michelangelo.
L’apertura ufficiale della biblioteca avverrà nel 1571, sancendo la fine dei lavori.
Il progetto di Michelangelo Buonarroti
Alcune parti dell’edificio non vennero modificate per volere del papa, come ad esempio il chiostro medievale. Michelangelo ha dunque adeguato il progetto tenendo in considerazione gli aspetti planimetrici preesistenti del chiostro.
La sala della lettura della Biblioteca Laurenziana
La sala lettura venne aggiunta, come un corridoio, alle parti già esistenti del chiostro. Questa scelta inconsueta fu la decisione più appropriata per ottenere un’illuminazione adeguata ad una sala di lettura.
Questo ambiente è illuminati da una luce “divina”, proveniente dall’alto attraverso le finestre del lucernario.
La sala lettura possiede delle dimensioni notevoli, lunga 46,20 m, larga 10,50 m, e alta 8,40 m. All’interno di essa è possibile ammirare il mobilio originale, anch’esso progettato su misura da Michelangelo stesso.
Le sedute per la lettura si sviluppano su due file di sedili con un corridoio centrale. Sul retro di ciascun sedile vi è un’apposito tavolo per la lettura.
La sala è ampiamente illuminata da entrambe le parti del corridoio grazie alle grandi finestre.
Nulla è lasciato al caso, nemmeno le decorazioni parietali. Le finestre sono incorniciate da spesse lesene che determinano anche le decorazioni del soffitto e del pavimento. Le lesene-pilastro che vediamo alle finestre hanno ancora un’aspetto quattrocentesco, ma nel complesso il trattamento delle mura risulta innovativo.
Michelangelo gioca con gli alti e bassi degli elementi che compongono la decorazione parietale. Crea diversi livelli di spessore, dove il punto più basso coincide con la finestra e la rispettiva cornice.
Nel livello intermezzo dello spessore della parete inserisce una cornice quadrangolare cieca, a sua volta incorniciata da un’altra cornice sporgente.
Il piano più sporgente della parte è rappresentato dalle basi delle lesene-pilastro, anch’esse sporgenti.
Michelangelo risolve un problema strutturale causato dalle mura preesistenti di epoca medioevale, molto fragili.
Egli ha dovuto ridurre al massimo il peso della sala lettura attraverso il sistema di rientranze a livelli, e alternanze di pilastri sui quali viene scaricato il peso, alleggerendo così l’intera struttura.
Giochi di materiali, giochi di colori nella Biblioteca Laurenziana
Michelangelo mette in evidenza le funzioni di post e lintel (supporti e supportati) degli elementi architettonici attraverso l’uso diversificato dei materiali.
Gli elementi sporgenti, le cornici, sono stati costruiti in pietra serena, una materiale di colore grigio chiaro. Questi elementi si stagliano sul muro in stucco bianco.
Michelangelo lasciò il lavoro incompleto per partire a Roma nel 1534. Solo le mura della sala lettura erano state completate, il restante venne aggiunto negli anni successivi. I lavori vennero svolti da altre maestranze che seguirono i progetti di Michelangelo.
La parte superiore dell’edificio venne completato solo nel 1904, quando vennero completate le tre finestre che si affacciano al chiostro.
Il Ricetto della Biblioteca Laurenziana
Nel piano superiore, tra chiostro e vecchia sagrestia, vi è un vestibulo, chiamato ricetto. Questo ambiente è separato dal resto del complesso attraverso una scala che porta alla sala lettura.
Il ricetto possiede un senso di oppressione e claustrofobia date le dimensioni.
Questo ambiente è illuminato dalle finestre del lucernario, donando una luce “divina” allo spazio.
Nel 1559 il progetto della costruzione della scala del ricetto venne affidato ad Ammannati. L’anno precedente, nel 1558, Michelangelo spedì come riferimento un modello in argilla. I lavori procedettero a rilento, e il ricetto rimase incompleto fino al 1800.
Prima del modello finale, sappiamo che Michelangelo ebbe dei ripensamenti sul suo stesso progetto. Nel 1525 Michelangelo rimuove la scalinata centrale unica per concepire tre scalinate che convergono in cima.
Questo sarà il progetto finale di Michelangelo. Ammannati ha realizzato il progetto facendo riferimento solo al modellino inviatogli da Roma.
La scalinata della Biblioteca Laurenziana
La scalinata tripartita occupa metà muro del ricetto, alto 10,30 metri.
La scalinata centrale si distingue dalle due laterali per la forma convessa.
- Ciascuna delle tre scalinate, divise da balaustre, possiede nove scalini nella parte inferiore.
- I primi tre gradini della scalinata sono più alti e più larghi.
- Il nono gradino di ciascuna scalinata culmina in un’unica piattaforma che fa da base per la seconda parte della scalinata unica
- Il primo gradino della parte superiore della scalinata è convesso, riprendendo lo schema della parte inferiore.
L’effetto grandioso della scalinata è data dai volumi e dagli elementi verticali delle mura. Questi elementi caratterizzano lo stile di Michelangelo dell’ultimo periodo della sua attività architettonica.
Decorazioni murali
La stanza del ricetto è quadrangolare e possiede mura alte 14,66 metri. Esse sono decorate da diversi elementi architettonici che si sviluppano in tre livelli.
Il trattamento delle mura è particolare. Michelangelo usa il piano come elemento tridimensionale da scolpire.
Nella parte centrale spiccano gli elementi verticali, ovvero le colonne appaiate, sei per ogni facciata, che si inseriscono all’interno delle mura. Tra di esse vi sono delle nicchie oblunghe con frontoni sporgenti che si alternano tra tondi e triangolari.
Questa alternanza di frontoni la ritroviamo anche in Palazzo Farnese a Roma, progetto al quale lavorò anche Michelangelo.
La parte superiore del muro è decorata con elementi piatti, come la cornice e le lesene. Le lesene della parte superiore corrispondono alle colonne del livello centrale.
La base delle colonne accoppiate si trova sopra il livello della scalinata , e i capitelli si trovano al di sopra della porta d’entrata della libreria.
L’entrata della Biblioteca Laurenziana
L’entrata è affiancata da due grand volute che si proiettano dal muro.
L’entrata e la scalinata, rispetto alla della lettura, possiedono altezze differenti. Il progetto originale di Michelangelo le voleva della stessa altezza. Venne scelta una nuova soluzione con un sistema di colonne diverso, più piatto per la sala lettura e più sporgente per l’anticamera e la scalinata, che corrispondono all’entrata alla biblioteca.
L’architettura imprigionata, la metafisica, la tragedia umana
Conosciamo le teorie di Michelangelo rispetto alla scultura. Egli concepisce la scultura come una figura che libera dal blocco di marmo, e lo scultore aiuta la figura a liberarsi di ciò che è in eccesso.
Egli concepisce l’architettura allo stesso modo: vediamo la colonna che si libera dal muro, o la scalinata che si slancia nella stanza, come se uscisse direttamente dalle mura d’entrata.
Troviamo inoltre un senso metafisico degli equilibri architettonici. Richiama l’architettura psicologica nell’opera di Giulio Romano (collegamento articolo Villa Lante e l’ansia dell’artista).
In Michelangelo vediamo che le edicole centrali del ricetto sembrano essere più pesanti degli elementi che la sostengono.
Come in Giulio Romano e l’ansia dell’artista, le forze attive in Michelangelo richiamano la tragedia umana e la precarietà degli equilibri.
Michelangelo da Bramante e Raffaello
Michelangelo adotta il vocabolario di Bramante e Raffaello modificandone il significato, o meglio, sovvertendone gli aspetti.
In Bramante vediamo un’armonia delle forme e degli equilibri, mentre in Michelangelo gli equilibri vengono a mancare, creando dei lintel molto deboli per far dominare i Post, ovvero gli elementi verticali.
I pilastri di Michelangelo sono si classici nella forma, ma assumono un a funzione gotica per la loro imponenza. Le colonne e i pilastri assumono un’espressività drammatica, atipica nell’ideale classico.