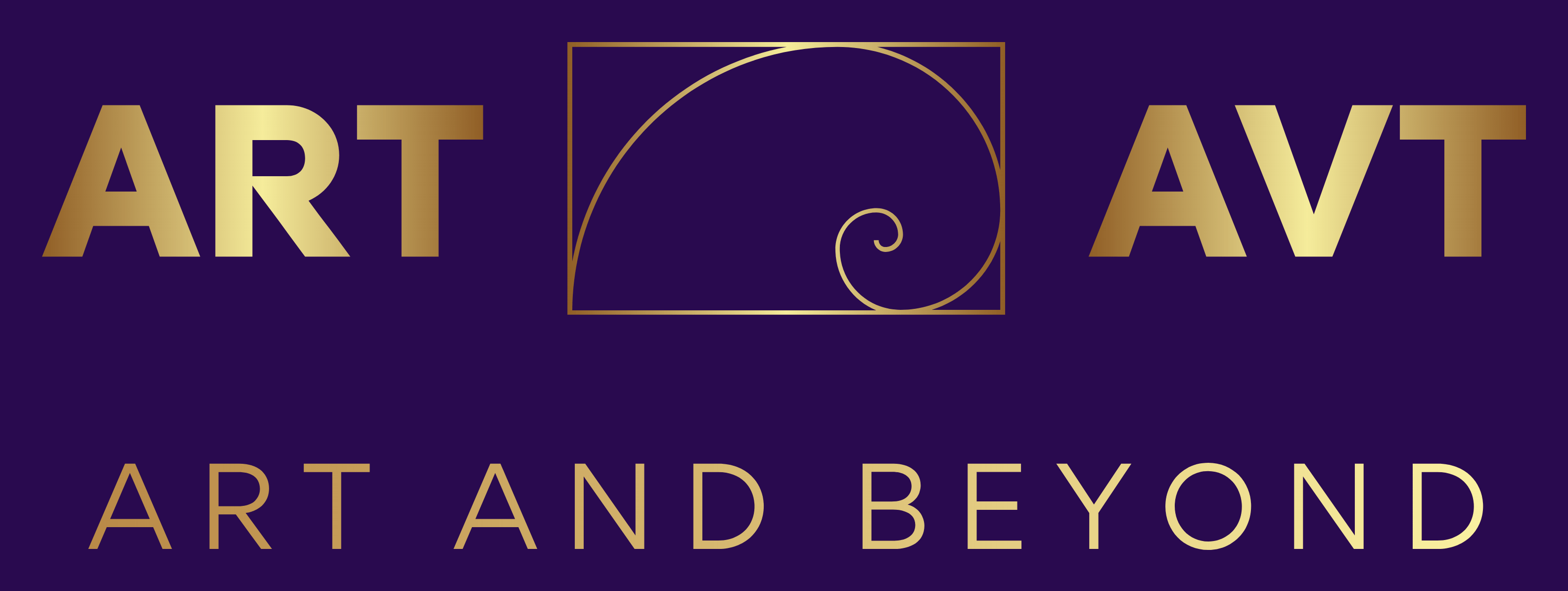Origine della chiesa
La chiesa di San Lorenzo a Firenze possiede un’origine molto antica. Prima che Michelangelo vi mettesse mano su di essa passarono secoli.
La prima costruzione della chiesa risale probabilmente al IV secolo, e nel 393 venne consacrata come cattedrale dedicata al martire San Lorenzo, e fu cattedrale cittadina per altri 300 anni.
Essa si trovava inizialmente poco fuori le mura, così come le altre primitive basiliche cristiane. Con il passare degli anni il centro cittadino di Firenze si allargò fino ad includere anche la chiesa di San Lorenzo, che oggi troviamo nel cuore della città. Di questa chiesa primitiva rimane ben poco, e pressoché nulla è stato rinvenuto da degli scavi archeologici avvenuti tra il 1960 e 1970.
Da cattedrale a chiesa
Successivamente la chiesa di San Lorenzo passerà lo status di cattedrale alla chiesa di Santa Reparata, che diventerà la nuova cattedrale.
La chiesa fu ampliata in epoca medievale nel 1059 quando divenne papa Gherardi di Borgogna, ovvero papa Nicolò II. A quel periodo risale la costruzione del chiostro al lato della chiesa.
Venne posto l’ordine di un nuovo ampliamento nel 1400. Nel 1418 vennero abbattute alcune case nei dintorni della chiesa per l’ingrandimento del transetto.
Giovanni Bicci de’ Medici finanziatore di San Lorenzo a Firenze
In questo periodo Firenze era guidata dai Medici. Giovanni Bicci de’ Medici fu un finanziatore del progetto e nominò Filippo Brunelleschi come architetto dei lavori in San Lorenzo che iniziarono nel 1421.
La sagrestia venne terminata nel 1428, mentre il resto dei lavori andavano a rilento.
Susseguirsi di maestranze
Nel 1441 Cosimo de’ Medici patrocinò la costruzione che passò nelle mani di Michelozzo,. Egli ereditò numerosi lavori lasciati incompiuti da Filippo Brunelleschi. Fu persino architetto del vicino palazzo Medici (collegamento articolo).
1475 io cantiere passa in mano a Manetti
1461 vviene consacrato l’altare maggiore.
1464 Cosimo de’ Medici viene sepolto in una cripta sotto l’altare maggiore.
I Medici, dopo un periodo di crisi, si tornano a Firenze nel 1515.
Papa Leone X decise di completare la facciata come simbolo della vittoria della famiglia medicea
Un progetto travagliato per San Lorenzo a Firenze
I lavori per la progettazione della chiesa furono molto travagliati, ma si arriverà a un accordo che affiderà la facciata a Michelangelo Buonarroti, il quale succederà a Giuliano da Sangallo, mentre la cappella privata della famiglia Medici verrà affidata a Filippo Brunelleschi.
L’interno della chiesa fu finito nel 1470. La facciata iniziata da Filippo Brunelleschi era ancora da completare.
Il suo progetto prevedeva una facciata ispirata a Santa Maria Novella o San Miniato.
Raffaello probabilmente fece un progetto del quale però non abbiamo alcuna testimonianza se non quelle scritte da Vasari nelle sue Vite.
Anche Giuliano da Sangallo fece dei progetti che poi vennero eseguiti. Nel 1516 Giuliano muore e Michelangelo prende il suo posto, il quale completerà la facciata sotto il pontificato di Leone X e Clemente VII.
Michelangelo creerà un modello in legno per la chiesa per la facciata che rispecchia anche i progetti dei suoi disegni.
Michelangelo dedicherà corpo e anima al progetto infatti passerà ben due anni nelle cave di marmo per scegliere i materiali della qualità più alta e per gestire i lavori di trasporto dei blocchi di marmo fino a Firenze.
Il progetto per la facciata di Michelangelo segue per sommi capi il progetto proposto da Sangallo:
La larghezza corrisponde alla sezione dell’incrocio, e le navate si sviluppano su due livelli.
Caratteristiche del progetto
Troviamo un ordine di colonne accoppiate che sorreggono una trabeazione di stampo classico. Sulla trabeazione si slanciano dei pilastri dalla base massiccia, e le quattro finestre presenti sono incorniciare da degli archi.
Possiamo notare la vena scultorea di Michelangelo nella massiccia presenza di sculture. Notiamo come egli concepisce l’architettura come un gruppo scultoreo, dunque nella sua totalità unendo le due arti gemelle in un unicum totale, gestendo i volumi e gli spazi in senso scultoreo.
Ricordiamo Michelangelo anche e soprattutto nel lavoro della volta della cappella sistina, dove un’architettura illusoria si fonde con lo spazio e ne delinea le forme. In quest’ultima unisce architettura e pittura, mentre a San Lorenzo unisce scultura e architettura.
Egli estremizza i paradigmi pittorici, architettonici e scultorei mostrandosi a noi nella sua opera per il grande genio che egli è.
Nella sua opera ritroviamo quell’unione, di matrice classica, tra uomo e architettura dove l’uomo diventa misura dello spazio.
Nel complesso la sua facciata di san Lorenzo ha un aspetto minimal, vi è un’economia dei volumi che si uniscono ai complessi scultorei in maniera naturale.
Per molto tempo questo modello e questi disegni non vennero riconosciuti a Michelangelo.
Sono andati perduti i modelli in cera delle sculture che sarebbero state inserite nelle nicchie, seguendo uno schema simile alla tomba di papa Giulio II, ma ancor più monumentale.
La nuova sagrestia
Questa è l’unica opera di design di interni di Michelangelo che è rimasta fedele alla sua idea originale senza lo stravolgimento continuo dei progetti. Ma l’opera non venne mai interamente compiuta.
L’idea era quella di far diventare la zona della tomba un mausoleo all’interno del transetto della chiesa, da qui nasce l’esigenza di spostare la sagrestia e modificare la pianta della chiesa.
La cupola è emisferica e presenta i cosiddetti cassettoni che richiamano il Pantheon romano. Viene utilizzata questa tecnica sia in senso strutturale, edificatorio e decorativo.
Con questo tipo di espediente egli innalza e slancia la cupola verso l’alto.
Troviamo dei pilastri solo nel coro della vecchia sagrestia brunelleschiana.
Troviamo nel resto dello spazio delle colonne con frontoni, mentre al di sopra delle porte troviamo delle edicole decorative.
Attorno alle porte ritroviamo delle cornici in marmo che sostengono dei tabernacoli allungati che vengono incorniciati a loro volta da pilastri e trabeazioni.
Le porte fanno parte di un apparato di supporto dominato da tabernacoli e cornici pesanti, infatti i lintel, ovvero gli elementi verticali sui quali poggiano, sono stati rinforzati da beccatelli.
Michelangelo aggiunge dei muri attorno ai pilastri in pietra serena che decora con nicchie, pilastri, trabeazioni e volute.
Lo stile di Michelangelo a san Lorenzo a Firenze
Lo stile di Michelangelo, secondo gli scritti di Vasari, è in contrasto con i canoni rinascimentali , infatti vediamo un Michelangelo architetto che si diletta nell’inventare nuove soluzioni stilistiche che sembrano portare la sua firma eclettica.
Egli tende ad eliminare ogni ostacolo fisico e visivo tra lo spettatore e lo spazio dando un ampio respiro all’intera opera.
L’effetto che lo spettatore può sentire da vicino è l’austerità della composizione grazie alle statue sovrumane che danno l’idea di spazio divino.
Lo spazio è illuminato dalla lanterna sovrastante che dà rilievo alle composizioni ordinate e geometriche che accompagnano lo spettatore lungo lo spazio riempito da figure nelle nicchie e sull’altare.
Successivamente verranno anche aggiunte le Biblioteche Laurenziane, ma questo è un argomento per il prossimo articolo.